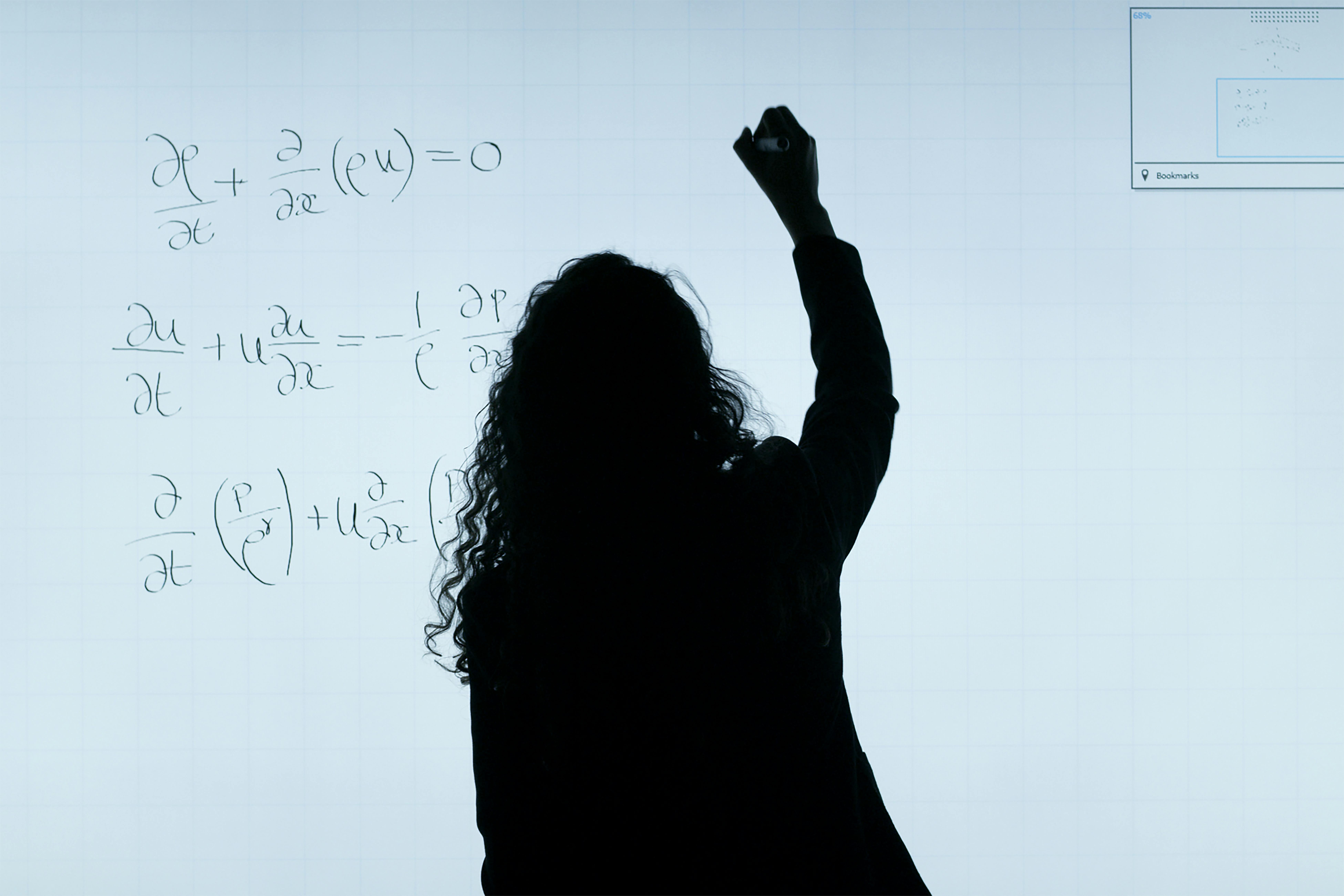Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) è un documento importante che definisce le strategie e gli interventi educativi per supportare lo studente.
Due aspetti sono rilevanti: la firma e la partecipazione dei genitori alla stesura del PDP:
- la firma dei genitori non è obbligatoria, ma è fortemente consigliata. La firma dei genitori indica l'accettazione e la condivisione del piano e delle strategie proposte;
- i genitori hanno il diritto di partecipare alla stesura del PDP e di esprimere le loro opinioni e richieste.
La normativa di riferimento è la Legge 170/2010 e le Linee Guida MIUR Decreto 5669 del 2011, che stabiliscono che il PDP deve essere redatto in collaborazione con la famiglia e, ove possibile, con lo studente.
Analisi dei punti chiave:
- Il PDP è un atto della scuola, redatto dal consiglio di classe sulla base della diagnosi e delle esigenze dell’alunno.
- La firma dei genitori serve solo a testimoniare la presa visione e la collaborazione, non è un atto di consenso.
- Il PDP è valido anche senza la firma dei genitori: la scuola ha comunque il dovere di applicare misure e strumenti compensativi/dispensativi previsti dalla legge 170/2010.
- Se i genitori non firmano, è buona prassi che la scuola annoti la mancata firma e conservi la documentazione dell’avvenuta condivisione.
Se i genitori non sono d’accordo con il PDP o vogliono chiedere modifiche:
1. I genitori possono chiedere chiarimenti o una revisione. I genitori hanno pieno diritto di:
- chiedere un incontro con il consiglio di classe o con il coordinatore;
- proporre modifiche a strumenti compensativi, misure dispensative o modalità di verifica
- segnalare ciò che ritengono non adeguato rispetto alla diagnosi.
La scuola dovrebbe accogliere la richiesta e convocare un confronto.
2. Se i genitori non firmano il PDP
La mancata firma non blocca l’applicazione del PDP.
La scuola lo applica comunque, annotando che i genitori:
- hanno visionato il documento, ma non hanno firmato o hanno espresso riserve.
La legge non prevede che il consenso dei genitori sia condizione per l’attivazione del PDP.
3. Se c’è un vero dissenso sul contenuto
In caso di forte disaccordo:
- la scuola può rivedere e aggiornare il PDP durante l’anno;
- i genitori possono presentare una richiesta formale scritta alla scuola per rivedere il documento;
- se necessario, ci si può rivolgere al Dirigente scolastico per una mediazione.
4. Le misure devono restare coerenti alla diagnosi
Il PDP deve sempre rispettare:
- la diagnosi clinica;
- la legge 170/2010;
- le Linee Guida MIUR Decreto 5669/2011;
- il principio del “successo formativo” dell’alunno D.P.R. 275/1999 art. 1 comma 2.
Quando i genitori non vogliono riconoscere che il figlio possa avere un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA), la situazione può diventare delicata sia per la scuola sia per il bambino.
Una possibile modalità di azione efficace può essere:
1. Partire dall’osservazione, non dall’etichetta. Bisogna evitare di parlare subito di “DSA”, ma rilevare che ci sono:
- difficoltà nella lettura;
- errori nella scrittura;
- lentezza nei calcoli;
- grande impegno ma scarsi risultati.
Mostrare dati oggettivi per prevenire situazioni conflittuali. Molti genitori temono che il DSA:
- “segni” il figlio;
- limiti le sue possibilità;
- sia colpa loro;
- comporti discriminazioni.
È utile spiegare che:
- Il DSA non è un deficit cognitivo;
- Non è “colpa” di nessuno;
- Molti studenti con DSA hanno ottimi risultati;
- Il riconoscimento serve a dare strumenti, non ad etichettare.
2. Mostrare i benefici concreti. Spiegare cosa cambierebbe con una certificazione:
- strumenti compensativi (lettura digitale, mappe, calcolatrice…);
- misure dispensative;
- modalità di verifica più inclusive;
- riduzione dell’ansia scolastica;
- un percorso personalizzato per valorizzare punti di forza.
3. Colloquio privato e tono collaborativo col dirigente scolastico
4. Offrire risorse chiare e oggettive
Fornire ai genitori:
- riferimenti dei servizi territoriali (NPIA, ASL),
- eventuali specialisti,
- informazioni semplici su cosa comporta una valutazione.
A volte la resistenza nasce dall’ignoranza o dal timore dei costi.
5. La scuola può
- redigere un PDP “informale” basato sui bisogni educativi, anche se non c’è certificazione, quando possibile e previsto dalla scuola;
- coinvolge il dirigente scolastico e il team docenti;
- documenta le difficoltà osservate.
6. Rispettare il tempo dei genitori. La negazione è spesso una forma di protezione emotiva.
Continua a:
- mantenere il dialogo aperto,
- dare feedback costruttivi,
- mostrare miglioramenti quando si applicano strategie didattiche inclusive.
7. Se la situazione diventa critica
Nei casi in cui:
- il disagio del bambino è evidente,
- c’è forte sofferenza scolastica o emotiva,
- il rendimento peggiora,
può essere utile coinvolgere figure autorevoli per spiegare le esigenze dell’alunno/studente:
- lo psicologo scolastico (se presente),
- il referente BES/DSA,
- un mediatore/servizi sociali che insistono sul territorio.
a cura di Tullio Faia