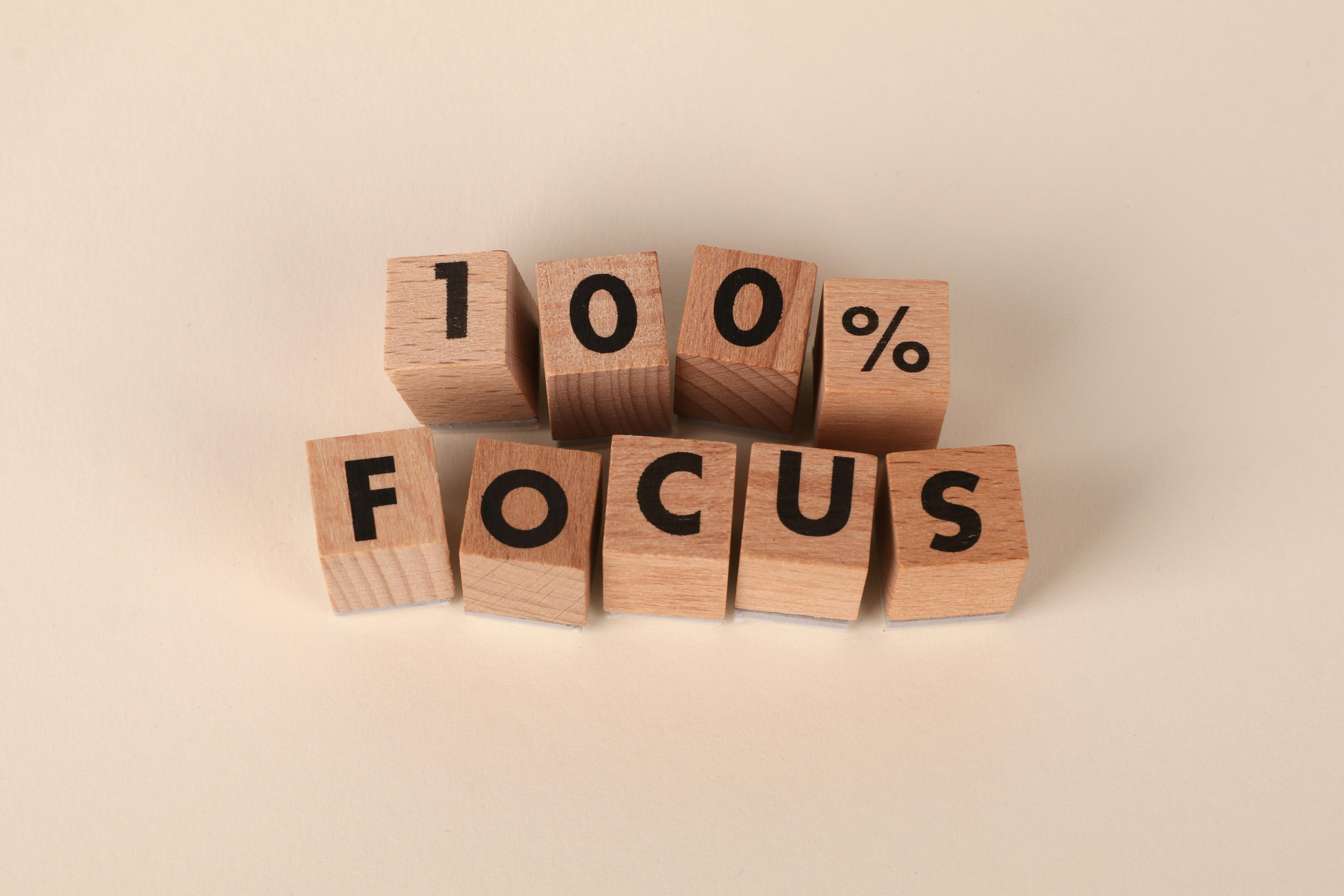Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema infortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva, in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative stressogene (c.d. straining), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti — per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto — possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno. Restano fuori dall'area della responsabilità i pregiudizi che derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante dell'ordinaria prestazione lavorativa oppure i meri disagi o le lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità.
Anche la tutela contro le tecnopatie da costrittività organizzativa rientra nel generale dovere di protezione della salute psico-fisica ex art. 2087 c.c. Ne deriva, conseguentemente, che lo straining può configurarsi non solo quando vi siano comportamenti stressogeni intenzionalmente attuati contro il dipendente, ma anche quando il datore di lavoro consenta, colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno per la salute dei lavoratori.
In questo caso, pur correttamente individuando la natura organizzativa e l'effetto stressogeno della conflittualità lavorativa interpersonale, la Cassazione continua ad “ancorarsi” alla categoria –di natura medico-legale e non giuridica- dello straining.
Cassazione civile sez. lav., 11/11/2022, n.33428