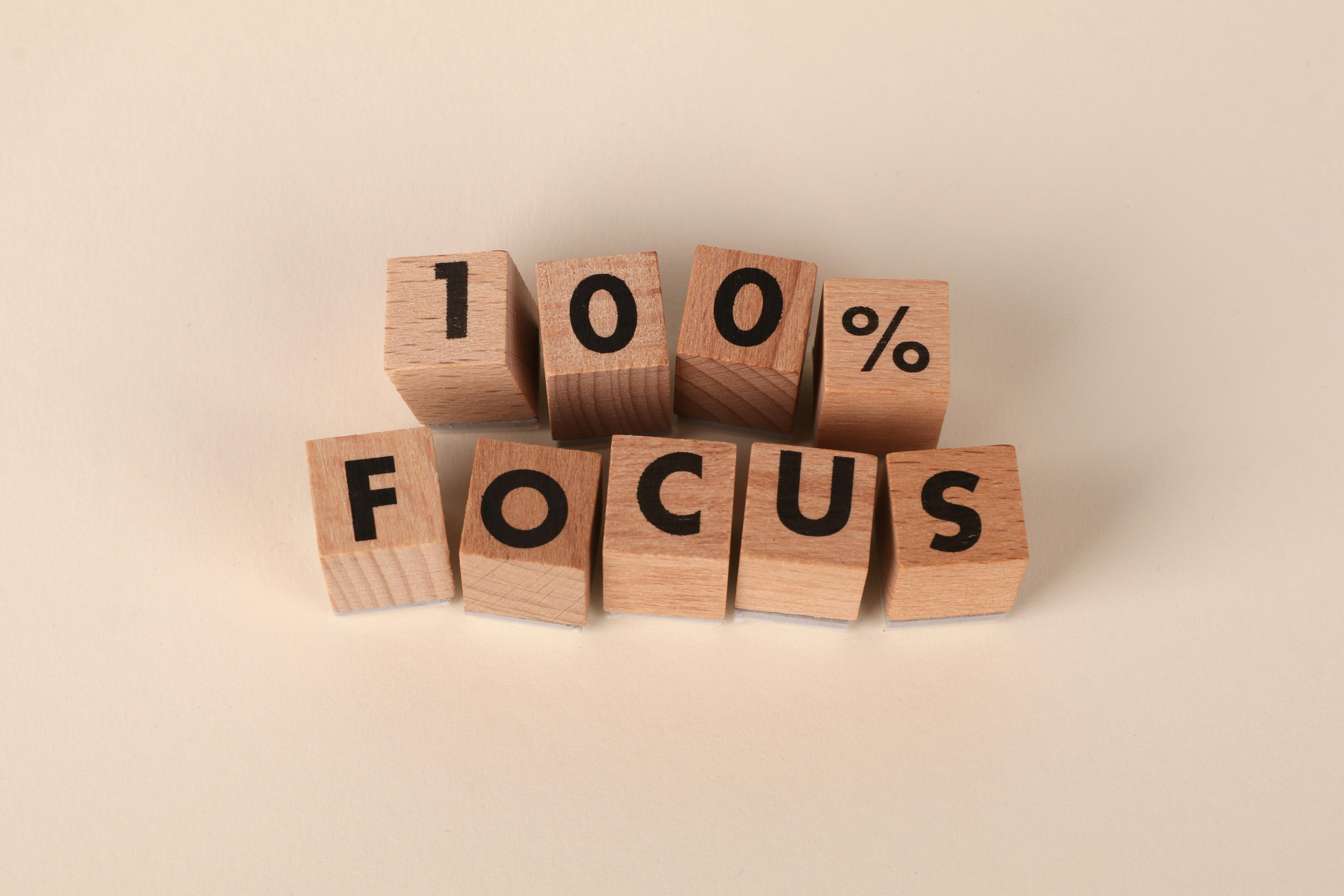I permessi ex art. 33, c. 6, L. 104/92 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che la fruizione del beneficio debba essere necessariamente diretto alle esigenze di cura.
La fattispecie in esame riguarda un lavoratore disabile che è stato licenziato per giusta causa per avere utilizzato i permessi ex art. 33, c. 6, L. 104/92 non per esigenze di cura dettate dal suo status di invalido, ma aggiungendo i giorni di permesso con lo scopo di aumentare i giorni di assenza dal lavoro in concomitanza con le festività.
Il tribunale di merito ha affermato che l'utilizzo dei permessi in continuità con giorni festivi non configura alcuna violazione disciplinare, in quanto i permessi di cui possono beneficiare i lavoratori disabili in base alla ratio della Legge 104/92 non devono essere necessariamente collegati a esigenze di cura, avendo essi la finalità di consentire al soggetto il pieno recupero fisico e psichico necessario per il suo inserimento nella vita sociale e lavorativa.
Il datore di lavoro presenza ricorso per cassazione sostenendo in particolare che i permessi sono utilizzabili esclusivamente per «scopi collegati direttamente all'esigenza di tutela e/o cura e/o assistenza e non certamente per finalità ricreative e/o personali, senza confusione con le esigenze di recupero delle energie psico-fisiche alle quali è preposto il diverso istituto delle ferie e senza utilizzi devianti dell'esercizio del diritto».
La Suprema Corte nel respingere il ricorso ha anzitutto ricordato che l'art. 33, comma 6 della Legge 104/92, prevede che il lavoratore disabile abbia la libertà di optare tra permessi giornalieri (due ore) o mensili (tre giorni) e di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito in un'altra sede lavorativa, senza il suo consenso.
Dette provvidenze sono in linea con quanto dispone l'art. 38 della Costituzione, perché favoriscono l'assistenza al disabile da parte dei congiunti a condizione che il lavoratore sia affetto da grave disabilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 3 e 33, della citata Legge 104/92.
La tutela e il sostegno del soggetto disabile sono quindi garantite sia a livello nazionale (artt. 2, 3, 38 Cost., Legge n. 68/1999), sia a livello internazionale (Direttiva 200/78/CE e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) anche tramite forme di tutela indiretta, ossia tramite agevolazioni che «costituiscono un articolato sistema di welfare, anche familiare, connesso lato sensu ai doveri di solidarietà sociale, quotidianamente costruito attorno al disabile».
L'esigenza di socializzazione per il disabile, secondo la Corte Costituzionale, è imprescindibile per lo sviluppo della sua personalità, come accezione del concetto di salute psico-fisica, che «costituisce un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.) e rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica riconosce e garantisce all'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Cost)».
Inoltre, come sottolineato dalla Corte di Giustizia Europea, non si può trascurare il fatto che il lavoratore disabile ha sempre più difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro.
Con riferimento all'utilizzazione dei permessi fruiti dai familiari (art. 33, comma 3, L. 104/1992), la Suprema Corte ricorda che «l'assistenza non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il soggetto non sia in condizioni di compiere autonomamente.
L'abuso va quindi a configurarsi solo quando il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall'assistenza, da intendere in senso ampio, in favore del familiare» (Cass. n. 1394 del 2020, Cass. n. 21529 del 2019, Cass. n. 8310 del 2019, Cass. n. 17968 del 2016, Cass. n. 9217 del 2016 e Cass. n. 8784 del 2015).
L'interesse primario cui è preposta la L. 104/1992 è infatti quello di «assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell'assistenza al disabile che si realizzino in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura».
Si è invece in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto, ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, che dell'ente assicurativo, nel caso in cui il dipendente si avvalga di tali permessi per attendere ad esigenze diverse dalla cura e dalla assistenza al disabile (Cass. n. 17968 del 2016).
Per la Corte di Cassazione, non si può d'altra parte non tenere conto del fatto che «I lavoratori portatori di handicap rilevanti, proprio perché svolgono attività lavorativa, sono gravati più di quanto non sia un lavoratore che assista un coniuge o un parente invalido: la fruizione dei permessi non può essere, dunque, vincolata necessariamente allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo - più in generale - preordinata all'obiettivo di ristabilire l'equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale». Da qui il trattamento di favore previsto per il lavoratore disabile rispetto ai familiari, senza che questo dia origine a una qualche forma di discriminazione, trattandosi di situazioni oggettivamente diverse.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la Suprema Corte ha affermato che la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio di cui alla massima, laddove ha escluso la configurazione di un abuso del diritto nella fruizione dei permessi da parte del lavoratore portatore di handicap grave per finalità non collegate ad esigenze di cura e ha escluso una situazione antigiuridica di rilievo disciplinare. I permessi di cui all'art. 33, comma 6, della L. 104/1992 sono infatti riconosciuti al lavoratore portatore di handicap «in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale».
Corte di Cassazione Sez. Lav. ord. 25 settembre 2020, n. 20243