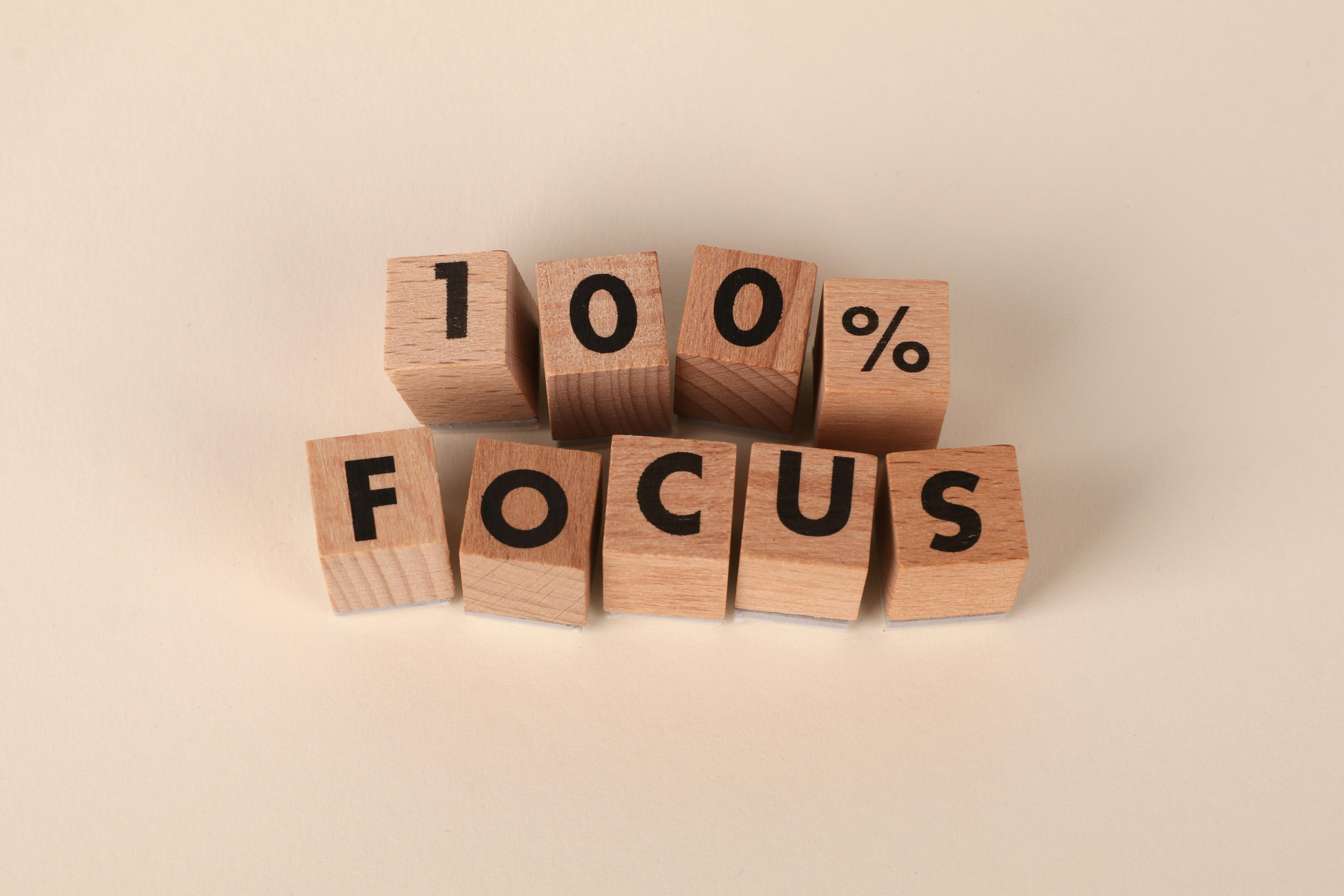Gentile redazione, ho un dubbio sulla modalità di svolgimento delle votazioni nel collegio dei docenti, pertanto chiedo il vostro autorevole parere.
Le votazioni si effettuano con una delle seguenti dichiarazioni: sì, no, astenuto.
E' possibile inserire nel regolamento di questo organo collegiale "il dirigente può richiedere, qualora lo ritenga necessario, di verbalizzare la motivazione del voto contrario di uno o più docenti a un punto dell'odg "?
Nel caso specifico un docente in un punto all'ordine del giorno "progetti della scuola" vota contro tutti i progetti, gli ho chiesto la motivazione e mi informa, forse a ragione, che non deve motivare il voto contrario. Capisco che possa anche non motivare ma non comprendo come si possa dare un voto contrario a tutta la progettualità della scuola. Il ds ha degli strumenti in casi così specifici?
Ringrazio e saluto
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra, le cose che si potrebbero dire sono tante, non ultima la mancata riforma degli organi collegiali, sperando che sia innovativa e non peggiorativa delle norme già esistenti molto carenti e non in linea con i nuovi poteri assegnati alla funzione dirigenziale.
Gli organi decisionali della scuola dovrebbero essere il dirigente e il consiglio d'istituto, nonché il consiglio di classe limitatamente alla delibera di scrutinio. Il collegio docenti in quanto organo eminentemente tecnico dovrebbe essere degradato ad organo consultivo, con pareri obbligatori, a supporto delle decisioni del dirigente e del consiglio d'istituto. Ma così non è per cui ci veniamo a trovare nella situazione delle problematiche descritte nel quesito che si riscontra. Si pensi solo all'assurdità della norma contrattuale che sottopone all'approvazione del collegio docenti il piano di lavoro contenenti gli obblighi di servizio degli stessi docenti.
Per cui non costituisce scandalo se il docente in seno al collegio docente può esprimere parere contrario senza motivare il proprio dissenso o addirittura avere la possibilità di astenersi dalle decisioni.
Entrando nel merito del quesito posto diciamo subito che sulla prima questione le norme esistenti non ci aiutano nel senso di poter imporre e pretendere la motivazione del voto contrario.
Nel procedimento deliberativo previsto dalle vetuste norme degli organi collegiali è previsto che la proposta messa ai voti può essere approvata o respinta all'unanimità oppure a maggioranza dei presenti o dei votanti.
Specificando che il voto finale che i componenti del collegio possono manifestare può essere:
-
favorevole rispetto alla proposta di deliberazione da assumersi: la somma dei voti favorevoli, esclusi i voti contrari e astenuti, determina, in caso di raggiungimento della maggioranza, la formazione della volontà collegiale e quindi l’assunzione della delibera; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente del collegio;
-
contrario rispetto alla proposta di deliberazione da assumersi: in via generale, non è obbligatorio motivare l’espressione di contrarietà (ma la motivazione potrebbe essere opportuna);
-
di astensione rispetto alla proposta di deliberazione da assumersi: in via generale, non è obbligatorio motivare l’espressione di astensione; l’astensione è espressione di un voto e come tale incide sul quorum deliberativo e sul grado di assunzione di responsabilità da parte del componente, in relazione alla deliberazione assunta. Non è, invece, sinonimo di non partecipazione al voto.
Ognuno dei componenti ha il diritto di far trascrivere il suo voto ed i motivi che lo hanno determinato, nonché di far registrare il suo motivato dissenso dalla deliberazione adottata dal collegio, anche al fine di essere esente da responsabilità potenzialmente derivabile dalla delibazione stessa. Questa facoltà non incontra limiti nemmeno nell’ipotesi in cui si debba votare a scrutinio segreto (vedi decis. Consiglio di Stato 24 febbraio 1970 n. 146, I, 248).
In questo senso le norme contenute nell' art. 37 del T.U. n.297/1994 in cui si stabilisce il principio generale secondo cui, affinché una deliberazione venga approvata, occorre che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ciò significa che non si contano gli astenuti e la deliberazione è validamente adottata con il voto favorevole della metà più uno dei votanti (Nota Ministero P.I. n.771/1980).
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Gli astenuti, quindi, concorrono nel numero legale per rendere valida la seduta, ma non si computano nei votanti agli affetti del calcolo della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Di conseguenza, una deliberazione si considera approvata quando riporta voti a favore pari alla metà più uno di coloro che hanno validamente espresso il voto (positivo o negativo), esclusi gli astenuti.
L’allontanamento dei componenti il collegio durante le votazioni non ha incidenza sul quorum deliberativo. Il docente che partecipa all’adunanza e poi si allontana al momento della votazione, non esprime un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il numero legale la constatazione della validità della seduta ad inizio seduta da parte del Presidente fa presumere la presenza del numero legale, salvo verifica contraria prima però di ogni singola votazione.
Oltre alla disposizione appena citata non rinveniamo nella legislazione scolastica una normativa specifica sullo svolgimento del processo decisionale e nemmeno sulle modalità di verbalizzazione.
Anche sul secondo aspetto del quesito la risposta non può che essere negativa. Vale a dire sulla possibilità di integrare le lacune della legge inserendo norme nel regolamento interno d'istituto. Ciò è possibile in linea teorica ma si scontra con il principio di gerarchia delle fonti. Nel senso che la norma regolamentare non può regolare in modo diverso quanto già previsto dalla legge.
Concludendo quanto osservato nel quesito è sacrosanto perchè è inconcepibile che il docente possa dare voto contrario su tutte le iniziative della scuola. La collegialità nel suo spirito originario quando è stata creata doveva avere la funzione coadiuvare motivatamente il processo decisionale nell'assunzione delle scelte di amministrazione al fine di perseguire l'interesse pubblico e non porsi, come adesso spesso avviene, come ostacolo alla decisione che è necessario prendere per il buon funzionamento della scuola. L'interesse dei singoli non può essere anteposto all'interesse generale.