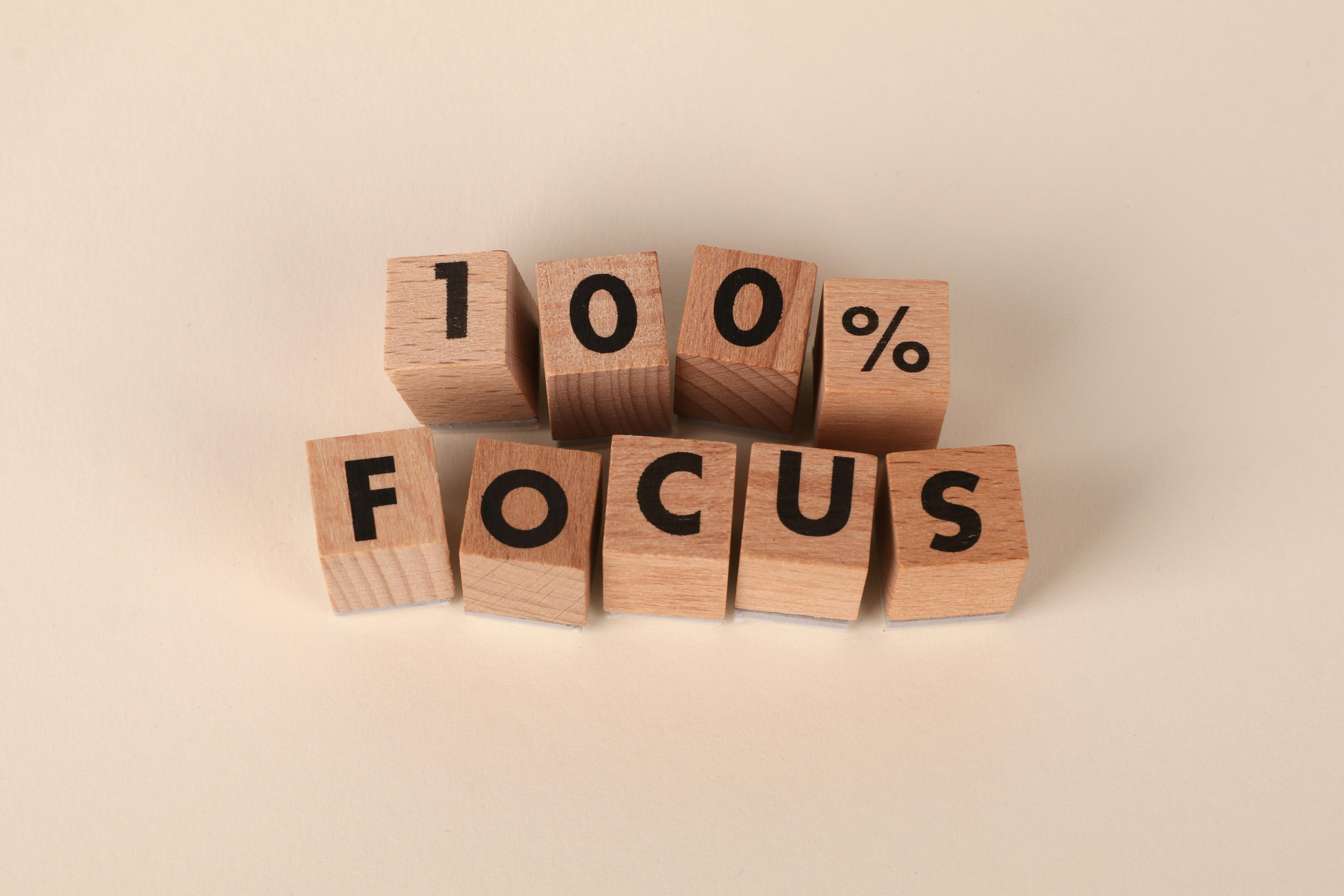Il 5 maggio è stata la giornata mondiale contro la pedofilia. Le implicazioni con la tutela della privacy dei minori dovrebbero oramai essere assodate. Ma non è proprio così. I casi di pedopornografia sono aumentati del 132%. “Numeri agghiaccianti - spiega Nunzia Ciardi, direttrice del servizio Polizia postale - Abbiamo notato una progressione preoccupante già negli ultimi anni”. Una tendenza che purtroppo non viene smentita dai primi quattro mesi del 2021: “Serve educare i giovani all’uso della Rete”.
L’isolamento sociale, la monotonia, l’impossibilità di avere relazioni che non siano mediate da uno schermo; a causa della pandemia di Covid-19, i bambini e i ragazzi si sono trovati a utilizzare sempre di più la tecnologia e la Rete. Ma proprio questa è tra le cause dell’importante incremento dei reati online contro i minori: pedopornografia, adescamento online, estorsioni sessuali, revengeporn, cyberbullismo e truffe sono le aggressioni subite dai più piccoli. Si tratta di una progressione preoccupante già negli ultimi anni, ma con la pandemia l’incremento ha toccato l’apice. Una tendenza che purtroppo non viene smentita dai primi quattro mesi del 2021, quando si è verificato un aumento del 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Solo da gennaio ad aprile ci sono stati 52 casi, contro i 41 dell’intero anno precedente. “La tecnologia è stata fondamentale per i più piccoli durante l’isolamento per mandare avanti l’istruzione con la didattica a distanza e li ha aiutati a mantenere i contatti con gli amici e i parenti. Ma questo uso massiccio ha avuto un costo molto alto, specialmente dove i bambini sono stati lasciati soli davanti al computer”.
Tra i dati preoccupanti, il report della Polizia postale evidenzia l’abbassamento dell’età delle vittime: sono sempre di più i bambini della fascia 0-9 anni a rischiare l’estorsione sessuale online. I piccoli vengono adescati, convinti a mandare immagini sessualmente esplicite e poi ricattati. L’adescamento della fascia 0-9 anni avviene soprattutto nelle chat delle app di gioco. “Numeri che indicano che minori di 13 anni sono stati lasciati soli in Rete per tutto il tempo necessario a queste operazioni - continua Ciardi - Per l’adulto non è facile comprendere con immediatezza che se il bambino è da solo in Rete corre un pericolo. Ma è proprio questa mentalità che bisogna combattere, cercando di far capire che per i più piccoli stare soli con un dispositivo è più pericoloso che esserlo in strada di notte: espone a qualsiasi rischio e a qualsiasi tipo di interazione”. Un dato altrettanto inquietante riguarda l’aumento dei minori autori di reato.
Negli ultimi 5 anni il numero dei minori denunciati per aver commesso reati online è cresciuto del 213% e si è anche abbassata l’età media degli accusati, da 16 anni a 15. Nel 91% dei casi sono maschi. Sono ragazzini che creano chat di gruppo in cui si scambiano video pedopornografici, immagini di abusi sessuali e video ‘gore’, filmati reali di violenze anche mortali inflitte a persone che provengono dal deep web, la parte meno accessibile della Rete. Tra i reati compiuti dai minori è in aumento anche il revengeporn: scambiano immagini e video sessuali delle loro ex fidanzate con il gruppo. Anche il cyberbullismo durante la pandemia ha registrato un incremento delle denunce del 96%. “La cosa pericolosa è che questi ragazzi hanno una consapevolezza molto labile, non si rendono conto dei reati che stanno compiendo. Questo non può che allarmarci, perché vuol dire che non hanno la minima educazione su come stare 4 in Rete”.
Come spiega la Polizia postale, negli ultimi anni si è appurato che vivere attraverso lo schermo abbassa la percezione della consapevolezza delle proprie azioni. Anche l’hate speech sui social nasce da questa incapacità comportamentale. La Rete viene spesso vista come una zona franca, dove non ci sono responsabilità per quello che si dice e si fa. Si comprende facilmente come un ruolo importante venga giocato dalle immagini che oggi, grazie ai dati biometrici sono facilmente associabili all’identità dei bambini e ragazzi. Il Consiglio d’Europa è intervenuto con una dichiarazione incentrata sulla protezione della privacy dei minori nell’ambiente digitale, adottata il 28 aprile 2021. Si legge che nel contesto della pandemia del Covid-19, gli Stati europei dovrebbero rafforzare le misure di protezione relative al trattamento dei dati personali dei minori, in particolar modo i dati riguardanti la loro salute e quelli raccolti nel quadro dell’istruzione, al fine di ridurre al minimo i potenziali effetti negativi, tra cui l’identificazione pubblica di un minore come portatore di Covid-19. Il Comitato dei Ministri ha espresso preoccupazione per le conseguenze e l’impatto della pandemia del Covid-19 sui minori a causa dell’aumento delle attività online e dell’utilizzo di prodotti e servizi online, o dell’esclusione digitale.
Tuttavia, il Comitato dei Ministri ha riconosciuto anche le opportunità e i vantaggi degli strumenti online, come la didattica a distanza e la possibilità di rimanere in contatto con familiari e amici, e chiede agli Stati di “esercitare maggiore vigilanza” e adottare misure per ridurre il divario digitale tra i minori, affinché tutti possano godere appieno dei loro diritti umani. Se questa è la situazione, il ruolo della scuola non solo educativo, ma anche in qualità di attore primario che spesso offre materiale per tutti i comportamenti criminosi richiamati. In concreto, mi chiedo come persista, da parte di moltissime scuole, l’abitudine a pubblicare sul sito web e sugli eventuali social dell’istituto immagini in chiaro dei bambini e ragazzi. E non voglio nemmeno riprendere, perl’ennesima volta, la spiegazione giuridica del divieto di diffusione di dati personali se non previsto da esplicita disposizione di legge o di regolamento. Quello che basta è il buon senso e la comprensione dell’obiettivo del diritto alla Privacy: la protezione dei dati che significa protezione delle persone in carne e ossa. Quando si realizzano i reati richiamati non è messa in discussione solo l’identità digitale del bambino, ma la sua stessa sicurezza psicologica e spesso anche fisica. Mi auguro che finalmente il Garante si esprima in modo chiaro e definitivo sui limiti da parte della scuola nella pubblicazione di dati personali.
Non basta più richiamare il seppure chiarissimo art. 2-ter del codice. Non riusciamo proprio ad interpretare la norma attraverso il filtro della responsabilità individuale. Siamo gente da norma-manganello (purtroppo!).
di Anna Armone, Editoriale di Scienza dell'Amministrazione Scolastica, n° 2, 2021