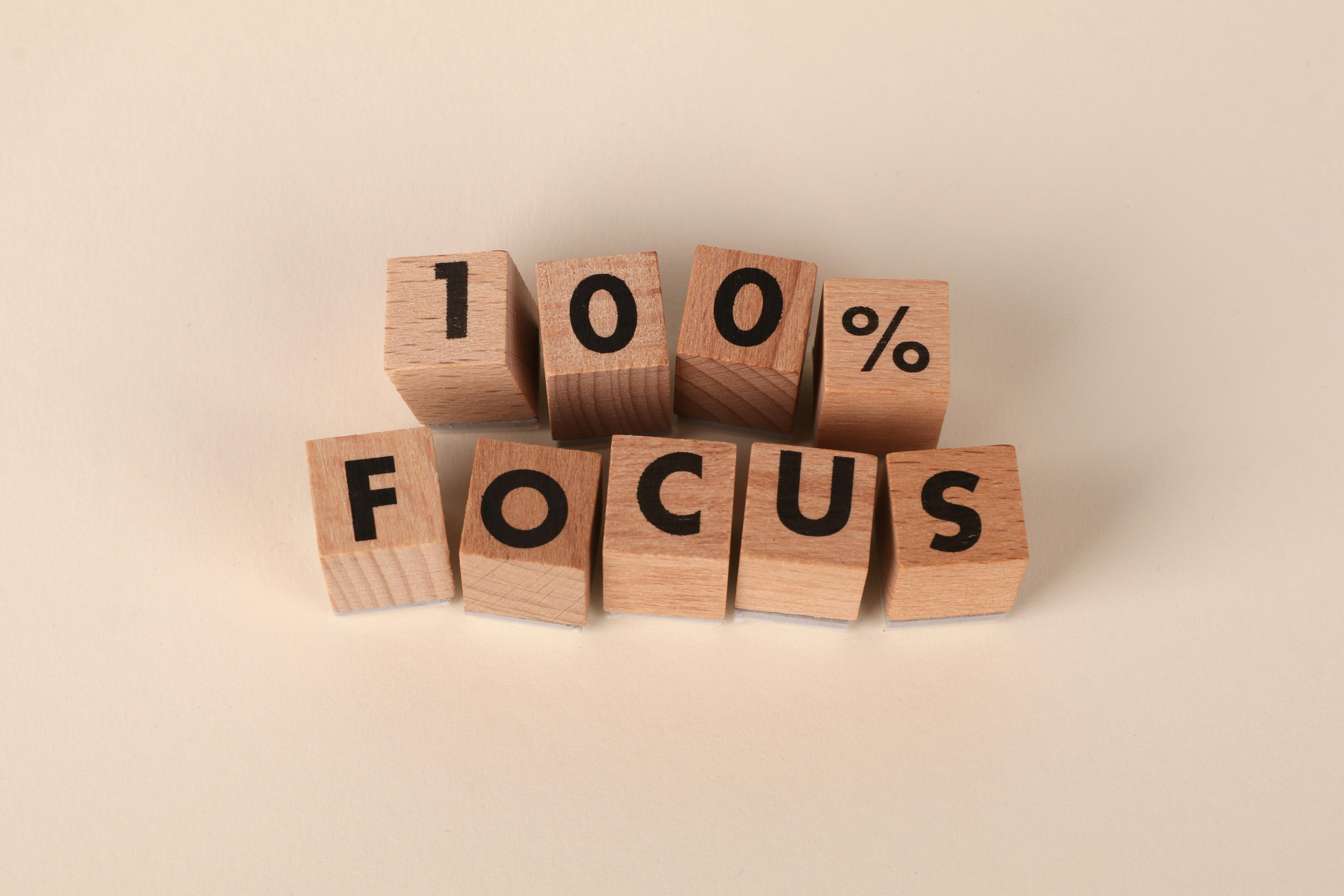La vicenda trae origine da un licenziamento disposto dal datore di lavoro per giusta causa nei confronti di un proprio dipendente che in un atto giudiziale aveva scritto frasi sconvenienti e offensive con il proprio datore di lavoro.
Il tribunale ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore condannando la società a reintegrarlo nel posto di lavoro. Il giudice nell'accogliere il ricorso del lavoratore aveva ritenuto le frasi scritte nel ricorso giudiziario, proposto dal lavoratore per ottenere le differenze retributive che assumeva gli spettassero, non contenevano "gravissime accuse" alla società e ai suoi superiori gerarchici e che fossero caratterizzate solo da veemenza nel sostenere le proprie tesi. Pertanto
Il giudice aveva escluso sotto il profilo soggettivo, "il reato di calunnia o di diffamazione avendo accertato che la condotta era rimasta nei limiti di «un'aspra critica finalizzata all'esercizio del diritto di difesa in giudizio".
Avverso la decisione del Tribunale il datore di lavoro propone ricorso per Cassazione rilevando come il giudice avesse escluso l'elemento soggettivo senza verificare in concreto se, al di là dello scopo prefissatosi, il lavoratore non si fosse coscientemente spinto fino al punto di accusare falsamente il datore di lavoro proprio per raggiungere l'obiettivo che voleva conseguire di annullamento dell'accordo economico, ed abbia così sconfinato nel reato di calunnia.
La Suprema Corte con sentenza dell' 11 luglio 2023, n. 19621, nel respingere il ricorso del datore di lavoro ha chiarito che integra il reato di calunnia, ai sensi dell'art. 368 c.p., la condotta di chi presenti denuncia, querela, richiesta o istanza diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, addebitando un fatto costituente reato ad un soggetto che egli sa essere innocente e che, ugualmente è ravvisabile tale reato nella condotta di chi simuli tracce di un reato.
La Corte di Cassazione evidenzia, inoltre, che il dolo nel reato di calunnia è ravvisabile «quando colui che accusa falsamente un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato», segnalando, infatti, che «l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata… esclude l'elemento soggettivo che è integrato solo nel caso in cui vi sia una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione)».
La consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato, continua la Suprema Corte, «è esclusa qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza» (Cass. Pen. 18/02/2020 n. 12209, 06/11/2009 n. 3964 e 02/04/2007, n. 17992).
Né può, prosegue la Corte di Cassazione, ravvisarsi l'elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale, in considerazione del tenore letterale della norma che richiede la necessità di una piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato (Cass. Pen. 14/12/2016 n. 4112, 16/12/2008 n. 2750).
La Suprema Corte chiarisce con specifico riguardo al diritto di critica del lavoratore, che «il suo esercizio nei confronti del datore di lavoro deve rispettare i limiti di continenza formale, il cui superamento integra comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro e può costituire giusta causa di licenziamento» (Cass. 18/07/2018 n. 19092) e che il superamento di tali limiti per un esercizio lecito della critica rivolta dal lavoratore nei confronti del datore «costituisce valutazione rimessa al giudice di merito, il quale, nella ricostruzione della vicenda storica, deve enucleare i fatti rilevanti nell'integrazione della fattispecie legale e motivare, rispetto a ciascuno di essi, circa il convincimento che tutti i predetti limiti siano stati rispettati, senza trascurare gli elementi che potrebbero avere influenza decisiva (…), nonché delineando l'iter logico che lo ha indotto a maturare detto convincimento» (Cass. 18/01/2019, n. 1379).
La Suprema Corte precisa poi che «il contenuto della memoria difensiva depositata dal lavoratore per resistere in un giudizio instaurato nei suoi confronti dal datore di lavoro non integra una giusta causa che legittimi il suo licenziamento, sebbene tale atto utilizzi espressioni sconvenienti od offensive posto che queste sono soggette a cancellazione e possono dar luogo a risarcimento ex art. 89 cod. proc. civ.».
Si tratta, secondo la Suprema Corte, di «documento giudiziario riferibile all'esercizio del diritto di difesa, oggetto dell'attività del difensore tecnico, al quale si applica la causa di non punibilità stabilita dall'art. 598 cod. pen. per le offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'Autorità giudiziaria quando concernano l'oggetto della causa».
In tal caso - sottolinea la Suprema Corte - va applicato il principio generale posto dall'art. 51 c.p. che individua la scriminante dell'esercizio di un diritto (o adempimento di un dovere) e che «è applicabile anche alle offese rinvenibili negli atti difensivi del giudizio civile sempre che riguardino l'oggetto del processo in modo immediato e diretto e che siano funzionali rispetto alle argomentazioni svolte a sostegno della tesi prospettata o all'accoglimento della domanda proposta» (Cass. 26/01/2007, n. 1757).
In definitiva, la Corte di Cassazione nel respingere il ricorso del datore di lavoro, ribadisce un principio già espresso in fattispecie analoga (Cass.11/12/2014, n. 26106) per escludere nel caso di specie la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento.
Precisa, del resto, la Suprema Corte come sia «ben vero che l'esimente di cui all'art. 598 c.p., che prevede che non siano punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, poiché la disposizione ricordata si riferisce esclusivamente alle offese e non può, pertanto, estendersi alle espressioni calunniose». Tuttavia, la Suprema Corte evidenzia che nel caso in questione la Corte di appello abbia accertato che tali dichiarazioni, erano strettamente connesse all'esercizio del diritto di difesa ed abbia rilevato l'assenza di finalità dirette a diffondere notizie idonee a screditare il datore di lavoro, escludendo la sussistenza del reato di calunnia posto a base del provvedimento espulsivo.
di Stefano Callà su I casi di scuola Dirigere la scuola n. 9