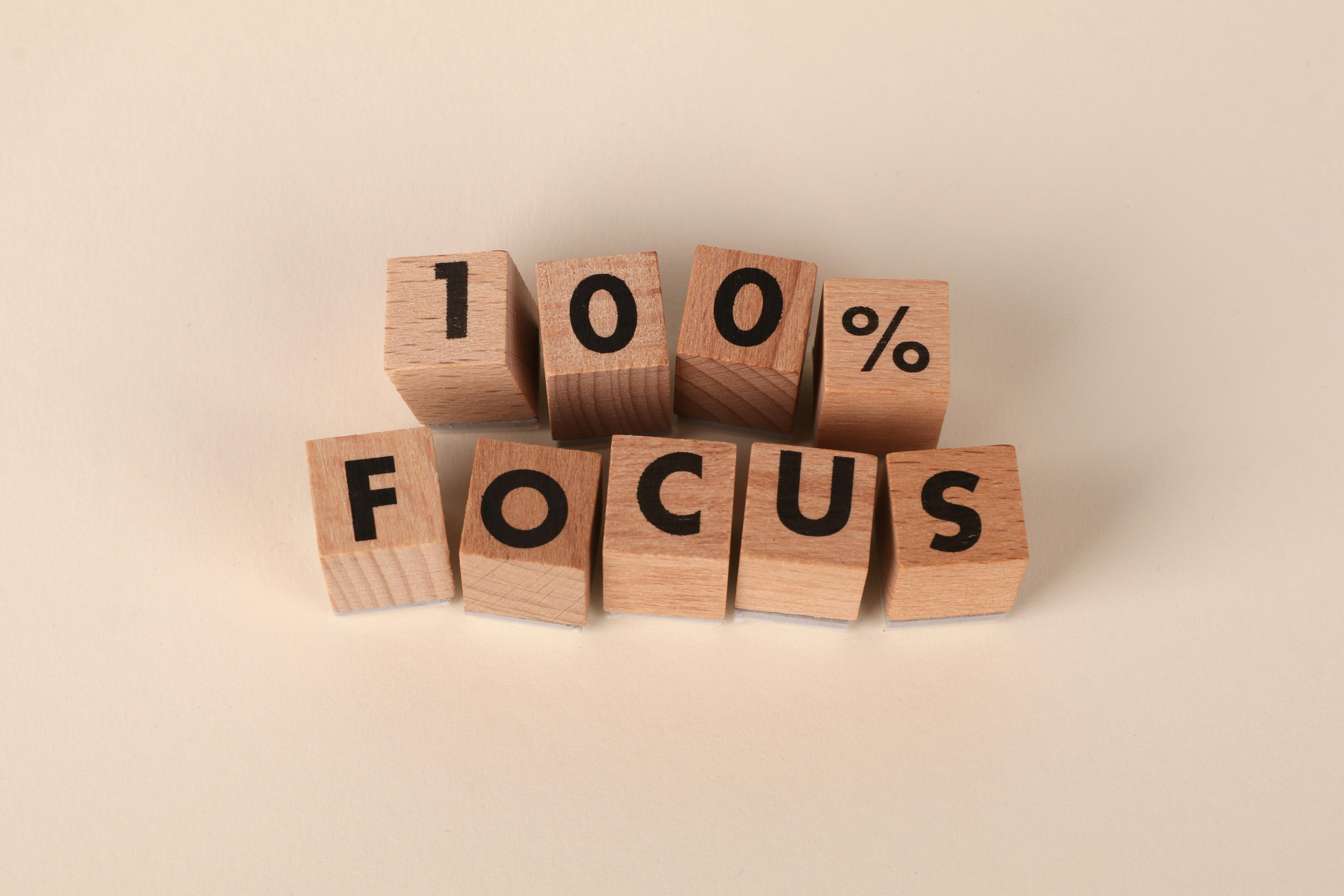Premessa
Un istituto comprensivo del veneto, nel dicembre 2023, deliberava una modifica del PTOF contenente la decisione di attivare, a partire dall’anno scolastico 2024/25, la strutturazione delle lezioni su cinque giorni settimanali, non solo per le nuove classi prime, ma anche per tutte le altre, tra le quali quelle già organizzate con orario distribuito su 6 giorni alla settimana.
La delibera fu preceduta da un sondaggio rivolto alle famiglie di alunni che già usufruivano della “settimana corta” e da un paio di riunioni con i genitori degli alunni delle classi con orario a 6 giorni, questi ultimi tendenzialmente contrari alla modifica prospettata.
Le motivazioni a sostegno della decisione di estendere la “settimana corta” a tutte le classi, contenute nella delibera del consiglio di istituto, adottata a maggioranza, furono le seguenti:
«spostamenti di allievi dopo non ammissioni più facili se stesso tempo scuola; non più problemi con il pulmino (escono tutti alla stessa ora); non più spostamenti costretti di bimbi perché non si poteva accontentarli (criteri CI); 2 ore di laboratorio per spostamento (rotazione ambienti) se orario di 6 ore giornaliero; chiusura degli uffici il sabato con conseguente allungamento durante la settimana (qualche pomeriggio in più, che non guasta per la segreteria, e qualche Collaboratore Scolastico in più durante la settimana; giorno libero per tutti il sabato; potenziato tutto a disposizione tra lunedì e venerdì (diversamente va garantita una quota per le classi residuali presenti il sabato».
Diversi genitori impugnarono la delibera ritenendola affetta da diversi vizi di legittimità: violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio di partecipazione, eccesso di potere per insufficienza/illogicità della motivazione.
Fonti normative
Le fonti che regolano la materia sono quelle relative all’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, alla redazione del Piano dell’offerta formativa, alla determinazione del calendario scolastico ed anche ai principi generali dell’attività amministrativa.
Procedendo con l’ordine indicato, l’art. 5 del DPR 275/1999 prevede che l’orario del curricolo e quello delle singole discipline sia organizzato «in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale […] previsto per le singole discipline e attività obbligatorie».
Dalla norma si ricava che alle istituzioni scolastiche è riconosciuta la facoltà di adottare tutte le forme di flessibilità ritenute opportune e funzionali alle esigenze didattiche, attraverso la pianificazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed attività, ferma restando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale o pluriennale del ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie.
L’art. 3 del citato DPR, così come modificato dalla L. 107/2015, prevede che il PTOF sia predisposto con la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica, entro il mese di ottobre dell’anno precedente al triennio di riferimento, con possibilità di revisione annuale. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente deve promuovere i necessari rapporti con gli enti locali e tener conto delle proposte e pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.
Questa norma, da leggere in combinato con l’art. 16 comma 5 -secondo cui «il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità»- consacra il principio di partecipazione.
Quanto alla determinazione del calendario scolastico, l’art. 138 del D.Lgs. 112/1998 assegna il compito alle Regioni che, in base a quanto previsto dall’art. 74 del D.Lgs. 297/1994, devono rispettare il vincolo di assicurare almeno 200 giorni di lezione.
Come chiarito dalla sentenza T.A.R. Liguria n. 59/2016, il numero minimo di giorni di lezione legislativamente previsto comporta, anche tenuto conto della norma che stabilisce il monte ore di lezione per ciascuna scuola, la strutturazione del calendario e conseguentemente dell’orario su sei giorni settimanali. Risulta agevolmente intuibile che, ove il numero minimo di giorni di lezione fosse riferito ad una calendarizzazione su cinque giorni settimanali, il monte ore di ciascuna scuola sarebbe ampiamente superato; in definitiva, il calendario scolastico, e prima di esso la norma di riferimento, è stabilito con riferimento ad una articolazione su sei giorni settimanali anziché cinque. Tuttavia, la stessa sentenza pacificamente conclude nel senso che è concesso alle singole istituzioni scolastiche la facoltàdi strutturare un orario settimanale su cinque giorni; ritiene il Collegio che tale scelta non implichi alcuna violazione del parametro relativo al numero di giorni (proprio nel presupposto che esso è fondato su una articolazione su sei giorni settimanali, anziché cinque). In altri termini, la normativa vigente non impone alle scuole una particolare articolazione settimanale delle lezioni, limitandosi a prevedere la “distribuzione minima” in cinque giorni alla settimana e lasciando loro la possibilità di scegliere discrezionalmente tra “settimana corta” (che non incide, violandolo, sul termine minimo di 200 giorni di lezioni) e “settimana lunga”.
Infine, va rammentato il contenuto dell’art. 1, comma 2 bis, della L. 241/1990, a norma del quale «i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede».
Questa norma consacra nel nostro ordinamento un principio di origine comunitaria, qual è quello del legittimo affidamento. E la questione merita uno specifico approfondimento, anche perché uno dei motivi del ricorso presentato contro la delibera del consiglio di istituto, riguardava, appunto, la violazione del “legittimo affidamento” dei genitori nel mantenimento dell’articolazione oraria su sei giorni settimanali, avendo gli stessi iscritto i loro figli in un momento in cui il Ptof prevedeva tale forma organizzativa delle lezioni.
Il principio di affidamento
Con la riforma del 2020 è stato introdotto nella L. 241/1990, tra i principi generali dell’attività amministrativa, quello della “buona fede”, che diviene un principio di condotta che opera sia con riferimento all’attività paritetica della pubblica amministrazione, sia a quella autoritativa. Come chiarito dalla giurisprudenza (TAR Napoli n. 5392/2023), «l'affidamento costituisce espressione di una situazione giuridica soggettiva di interesse legittimo tutte le volte in cui la fiducia tradita del privato si rapporta all'esercizio di un pubblico potere (non quindi a un comportamento mero, privato o materiale), da parte della p.a.»
La disposizione ha positivizzato una regola di carattere generale dell'agire pubblicistico dell'amministrazione, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e che porta a compimento la concezione secondo cui il procedimento amministrativo - forma tipica di esercizio della funzione amministrativa - è il luogo di composizione del conflitto tra l'interesse pubblico primario e gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti nell'esercizio del primo. Per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa, il procedimento necessita pertanto dell'apporto dei soggetti a vario titolo interessati, nelle forme previste dalla legge sul procedimento del 7 agosto 1990, n. 241.
Pur sorto nei rapporti di diritto civile, con lo scopo di tutelare la buona fede ragionevolmente riposta sull'esistenza di una situazione apparentemente corrispondente a quella reale, da altri creata, l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo.
Sostanzialmente ciò significa che la PA, nell’esercizio del suo potere, deve tener conto del fatto che i destinatari dell’azione amministrativa fanno affidamento sul corretto operato dell’amministrazione.
Inoltre,il principio ha una portata bilaterale, perché sorge nell'ambito di una relazione che, sebbene asimmetrica, è nondimeno partecipata; ed in ragione di ciò esso si rivolge sia all'amministrazione che ai soggetti che a vario titolo intervengono nel procedimento.
Ci si può chiedere se tale principio possa rilevare come vizio di eccesso di potere, ma, come chiarito dall’adunanza plenaria del Cons. Stato, sent. n. 21/2021, «le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l'altro concernente invece la responsabilità dell'amministrazione e i connessi obblighi di protezione in favore della controparte».
Principio recentemente confermato dal Cons. di Stato con sent. n. 1954 del 28.02.2024: «l'ipotetica lesione di tale principio rileva sul piano delle regole di responsabilità, non sul piano delle regole di validità degli atti».
Conseguentemente l’eventuale lesione del legittimo affidamento non determina l’illegittimità dell’atto amministrativo, potendo semmai rilevare come fonte di responsabilità per l’Amministrazione, sia nel caso di atto legittimo, sia nel caso di provvedimento illegittimo.
Il principio trova il suo fondamentale ambito applicativo ai provvedimenti di secondo grado (annullamento, revoca) ed all’attività contrattuale della PA.
La decisione
La sentenza in esame esordisce rammentando che gli atti di programmazione (come tale, quindi, qualificando la decisione sull’organizzazione oraria) costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale e quindi sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di vizi procedimentali e/o di carenze logiche e motivazionali.
«In particolare, la decisione dell’istituto di adottare la settimana corta riguarda il merito dell’azione amministrativa e, come tale, non può essere sindacata in sede giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità» afferma, infatti, la corte.
Nega poi che, nel caso concreto, i ricorrenti potessero nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento dell’orario distribuito su sei giorni alla settimana per tutti gli anni del percorso scolastico, perché il Ptof è, per espressa previsione normativa, annualmente rivedibile.
In tema può citarsi un’altra decisione (TAR Venezia, sent. 842/2018) che afferma l’erronea invocazione del principio di affidamento «in quanto tale principio tutela la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici e si traduce nell’affermazione che una situazione di vantaggio assicurata al privato da uno specifico e concreto atto dell’autorità amministrativa non possa essere rimossa se non alla ricorrenza di certe condizioni; orbene, la sua tutela postula la presenza di un elemento oggettivo (oltre a quello soggettivo e temporale) costituito da un provvedimento che attribuisce inequivocamente e concretamente un vantaggio; ma è proprio questo elemento a difettare nel caso in esame, in quanto gli atti di programmazione in questione sono scevri da logiche di distribuzione di “utilitates”, id est di vantaggi (o svantaggi) che ai singoli possono derivare (in una prospettiva eminentemente soggettiva e personale) dalla medesima programmazione».
Il TAR veneto aggiunge inoltre che il Consiglio di Istituto ha assunto la decisione (in data 13 dicembre 2023) con una tempistica sufficientemente ampia, tale da permettere alle famiglie interessate di valutare se, dall’anno scolastico successivo, iscrivere i figli presso altri istituti con classi ad orario distribuito su 6 giorni.
La corte respinge anche il motivo di ricorso fondato sulla violazione del principio di partecipazione, dando atto che i genitori erano stati coinvolti, tramite sondaggio e riunioni, e che, in ogni caso la decisione «è stata assunta dal consiglio di Istituto che ne ha la competenza e nel quale sono rappresentate anche le famiglie degli alunni per il tramite dei componenti che esse hanno eletto».
Infine, reputa sufficiente la motivazione addotta posto che «gli atti di pianificazione costituiscono atti con finalità generali e contenuto altamente discrezionale, con la conseguenza che l’obbligo di motivare le scelte pianificatorie ivi espresse è adeguatamente e sufficientemente soddisfatto con l’indicazione dei criteri generali e di massima che presiedono alla redazione degli stessi».
Conclusivamente vale la pena di riferire che ad analoga decisione è giunto, nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (rimedio giustiziale previsto dal DPR 1199/1971), vertente sui medesimi vizi, ilConsiglio di Stato con parere n. 177 emesso il 21 febbraio 2024. In esso si ripercorre grosso modo il medesimo iter motivazionale.
Innanzitutto, si afferma che la modificabilità annuale del Ptofesclude in radice la possibilità chepossa legittimamente ingenerarsiun affidamento sulla stabilità della strutturazione oraria settimanale delle lezioni.
Afferma inoltre che la modifica, ove effettuata oltre il mese di ottobre, previsto dalla legge, non ridondi comunque in illegittimità tutte le volte in cui la stessa venga effettuata in tempi tali da consentire comunque la tempestiva scelta di iscrizione o modifica di iscrizione nella cognizione delle modificazioni medesime.
Ritiene inoltre adeguate le motivazioni della decisione della “settimana corta” così individuate nel caso d specie: «1) maggiore recupero psicofisico degli studenti; 2) ottimizzazione dei turni di lavoro del personale; 3) articolazione della didattica in modo più funzionale; 4) possibilità, durante i rientri pomeridiani, di svolgere attività extracurricolari; 5) risparmio energetico avendo due giorni di chiusura della scuola a settimana, anziché uno. […] Né il Collegio può indagarne nel merito la bontà, impingendo in attività riservata all’Amministrazione, trattandosi di valutazioni per le quali l’esame del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere, che nella specie non risulta sussistente, trattandosi di ragioni plausibili a supporto della scelta discrezionale effettuata».
Infine, anche sul vizio relativo al difetto di partecipazione, che anche in questo caso è avvenuto con un contestato sondaggio dei genitori, la Corte rileva che appare irrilevante la circostanza che il sondaggio abbia avuto una partecipazione limitata, perché ciò che rileva è che sia stato espletato, a prescindere dall’ampiezza della partecipazione e dall’esito, anche perché l’esito del sondaggio dei genitori non è considerato dalla norma un parere vincolante.
Commento a sentenza del TAR Veneto n. 575 del 25.03.2024
di Gianluca Dradi